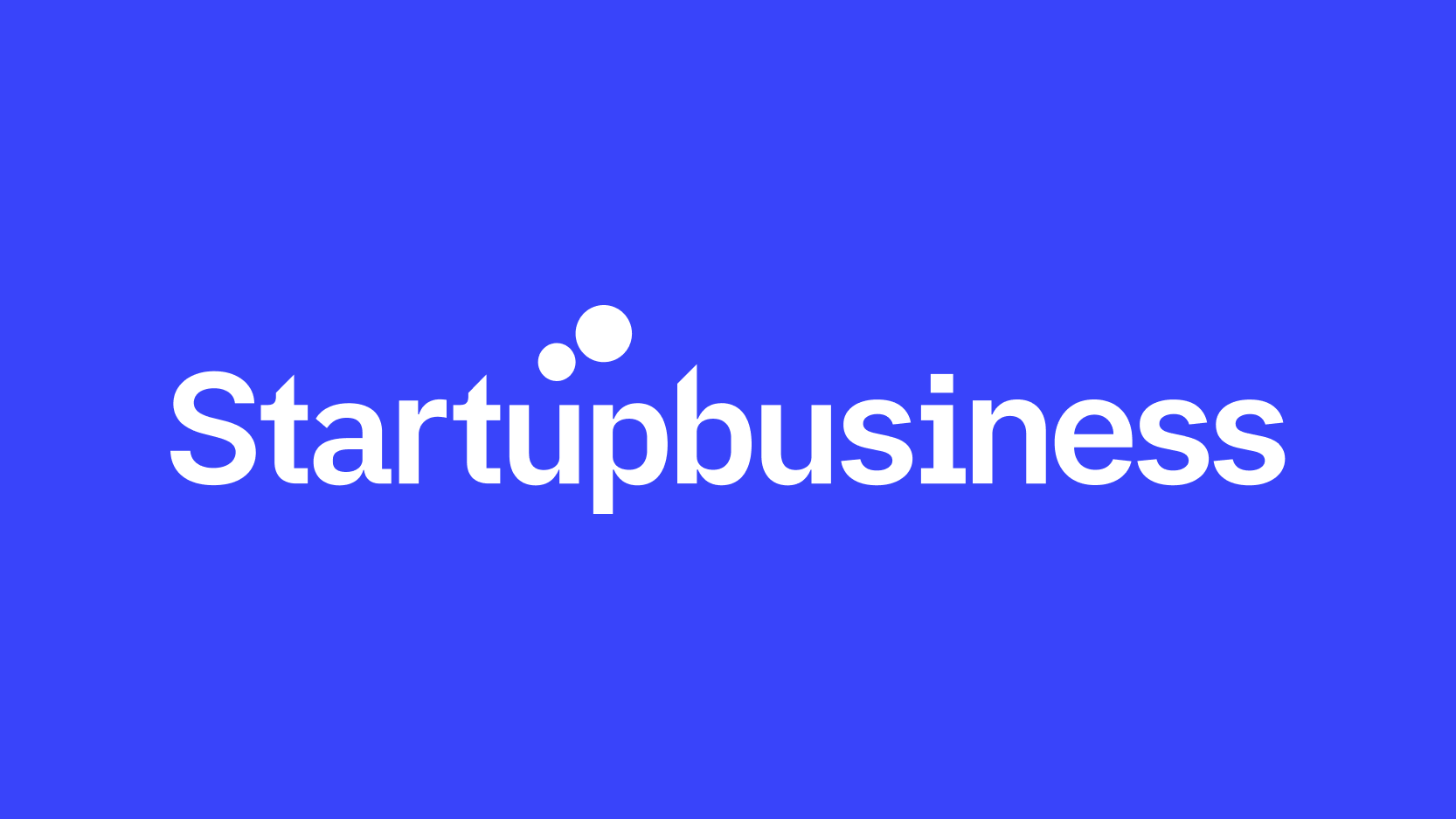Le riforme fondamentali in un’economia mista, che dovrebbe vivere parzialmente di mercato e parzialmente di Stato, con variazioni tra le due percentuali che dipendono strettamente dall’ambiente politico, culturale e sociale instaurato nello specifico paese.
L’Italia vive una situazione particolarmente complessa, dove a fronte di una massiccia presenza dell’attore pubblico – pensate soltanto che gli appalti valgono ben il 16% del PIL – e una tassazione a livello scandinavo se non più (con una total tax rate che oscilla attorno al 70% per le imprese) si ottengono servizi di qualità molto inferiore agli standard nordici.
Nonostante queste circostanze e limitazioni sistemiche, una visione equilibrata del sistema economico non può prescindere dal vedere la corresponsabilità degli attori che vi partecipano, in questo caso le imprese – vedasi il rapporto malsano tra un certo tipo di imprenditoria e lo Stato – sia dal lato di coloro che si affacciano sul mercato del lavoro.
Partiamo da questi ultimi. Gli italiani soffrono di un gap cronico di competenze digitali che l’Europa certifica da qualche anno a questa parte. Secondo Eurostat, quasi il 40% della popolazione non ha mai usato un computer, e meno del 50% possiede le abilità di base nell’utilizzo degli applicativi d’ufficio. A questi dati si aggiungono una percentuale bassissima di laureati – solo il 19% della fascia compresa tra i 25 e i 34 anni – con sempre meno incentivi a portare a termine un ciclo di studi avanzato, vista la stagnazione dei salari e l’assenza di diffusa meritocrazia sia nel pubblico che nel privato.
Secondo: le imprese. Da una parte PMI e grandi realtà estremamente innovative (come Saipem, controllata di ENI, avanguardia nelle tecniche di estrazione petrolifera avanzata), capaci di sostenere l’export e tenerci a galla. Dall’altra piccole imprese provinciali e proiettate esclusivamente sul mercato interno, in cui il livello di competenze digitali è talmente basso da impedire di cogliere eventuali innovazioni e possibilità di business.
Gli indici europei. Questa settimana poi si è aggiunta la tegola dell’Innovation Union Scoreboard 2014, promosso dalla Commissione, che certifica il distacco di alcune regioni all’intero dell’Unione, dividendole in quattro classi: innovation leaders, innovation followers, moderate innovators e modest innovators. Se i soliti paesi del blocco nordico agguantano la testa della corsa, l’Italia si ritrova nella parte bassa della classifica, ben al dì sotto della media UE.
Le motivazioni storiche. Come si può giustificare una situazione di questo genere agli occhi della storia? L’Italia è sempre stata una nazione di pionieri e innovatori da esportare – individui figli di una cultura in parte sacra e in parte profana che precede di gran lunga l’onda individualista degli anni ’80. Una possibile risposta potrebbe risiedere nell’incapacità di coniugare realtà locali di successo e fare sistema, e nel cronico dualismo proprio del bel Paese.
Come se ne esce? La risposta risiede certamente nelle riforme strutturali, e dunque dal lato delle istituzioni, che per loro natura dovrebbero fungere da aggregatore di buone pratiche. Dall’altra, dovremmo attendere una rivoluzione copernicana del modo di fare impresa di una larga parte del tessuto imprenditoriale italiano. E a giudicare dall’ora che si è fatta, nonostante il proverbiale ritardo della politica, la seconda sembra altamente più improbabile di una qualunque riforma della legge elettorale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA