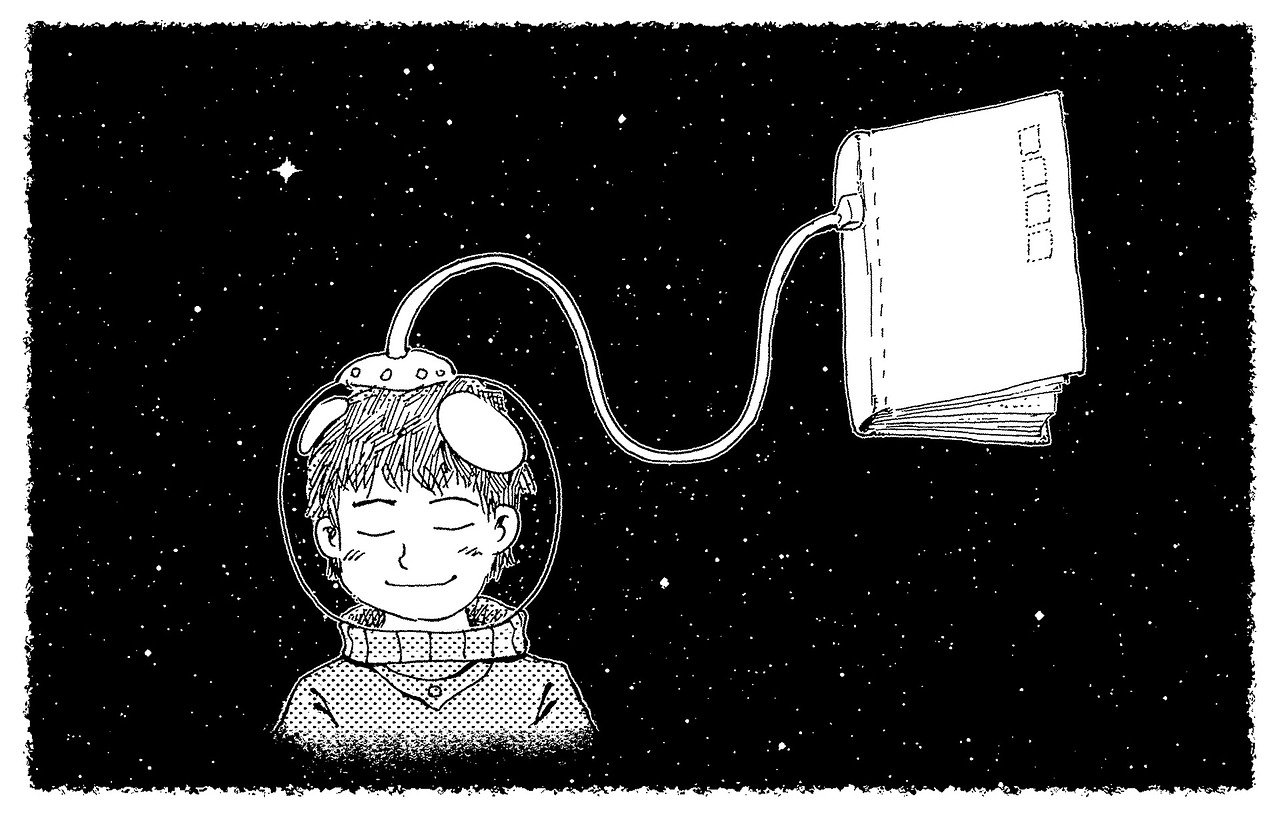Era il 2013 e né io né Emanuela Furiosi, la mia fidanzata e co-founder di bookabook, avevamo mai pensato di lanciare una start-up. A dirla tutta, io lavoravo in università, lei doveva ancora laurearsi. Avevamo quindi salutato con entusiasmo l’inizio dell’estate, che per noi quell’anno avrebbe significato Barcellona, relax e qualche bella lettura. Mio malgrado, nella valigia avevo dovuto fare posto a dei saggi e a qualche articolo sul crowdfunding, fenomeno che stavo studiando proprio in quel momento. Così, in quell’ozio estivo fatto di tapas, ramblas, vino tinto e camminate senza meta nella città catalana, discutevamo di editoria, nostra comune passione e settore allora in crisi nera, e della ricerca che stavo seguendo, sul crowdfunding appunto. Di quest’ultimo argomento ci affascinavano le potenzialità, i risultati raggiunti negli States e non solo. Come spesso accade ai discorsi estivi, i due argomenti finirono per mischiarsi. Non mi ricordo chi dei due azzardò l’idea “ma se provassimo ad applicare il crowdfunding all’editoria?“. Ci lasciammo Barcellona alle spalle, ma quell’idea venne con noi. Iniziammo a studiarla più a fondo e scoprimmo che, altrove nel mondo, era già venuta ad altri. E che il crowdfunding in Italia aveva numeri e realtà molto diversi da quelle d’oltreoceano. Non ci perdemmo d’animo. A dicembre costituimmo la società con altri soci, qualche mese di sviluppo e il 2 aprile 2014 eravamo pronti al debutto. Era impossibile non sorprendersi per l’entusiasmo che si era creato attorno alla nostra idea. Accostare start-up ed editoria allora era quasi un ossimoro e l’evento di lancio fu un successo di pubblico inaspettato. E anche di critica, se si considera che tra televisione, radio e giornali per tutto il primo mese non passò giorno senza una nuova opportunità di raccontare quello che stavamo facendo. L’idea di trasformare i lettori da consumatori a parte attiva del processo editoriale era semplice, ma efficace. Alla visibilità seguivano i primi pre-ordini sul sito. Tutto sembrava andare nel verso giusto. Ma l’entusiasmo iniziale finì in fretta. Dopo un paio di mesi fu chiaro che la sovraesposizione era finita, così come la nostra liquidità, e che spendevamo molto molto di più di quanto incassavamo. Ci servivano soldi, investitori. E il peggio è che ci servivano in fretta. Iniziammo a girare come trottole per pitch, caffè con potenziali investitori, business angel, banche, acceleratori. Tante pacche sulle spalle, qualche complimento. Ma nessuno era disposto a investire su un settore in crisi e con previsioni tutt’altro che rosee. Capii che eravamo al capolinea quando mi trovai a un appuntamento con il fondo di investimenti di un grande gruppo editoriale italiano. Finalmente mi facevano domande sul nostro settore, ero felice di rispondere anche a quelle più ostiche. Poi si congedarono augurandomi tutte le fortune del mondo: loro avevano già molti investimenti in editoria e dovevano diversificare. A un anno dal lancio il game over era pressoché certo. Poi avviene il quasi miracolo. L’ennesimo pitch, fatto più per non lasciare nulla di intentato che con delle speranze, finalmente si rivelò un semaforo verde. Entrammo in una rete internazionale di sostegno e sviluppo delle start-up, Réseau Entreprendre. Ci diede quello di cui avevamo bisogno e di cui credo abbia bisogno qualsiasi nuova attività: un network solido, un modello di business sostenibile, consulenze di altissimo livello. Il cambio di passo produsse un notevole risultato, entrammo infatti in un percorso di accelerazione ad Amsterdam e arrivammo secondi al contest europeo sull’innovazione in editoria. Dopo alcuni intensi mesi in Olanda, tornammo e scoprimmo di non avere bisogno di investitori. Avevamo una strategia che prevedeva una forte scalabilità senza interventi esterni. “Se sentirete il bisogno di aprire il capitale sociale” ci avevano raccomandato durante il percorso “lo potrete fare quando la società varrà di più, avrà una user base e delle traction capaci di attirare grandi investitori”. In gergo si chiama bootstrapping, nella nostra esperienza significa vedere i propri limiti (economici, di competenze, di mercato) come uno stimolo per migliorare il modello. Pensare nella scatola stretta anziché fuori dalla scatola. Serve molta umiltà, un giusto equilibrio tra autostima e autoironia, ma soprattutto la capacità di chiedere aiuto quando le cose non vanno come dovrebbero. Quasi sette anni dopo quel 2013, bookabook è una PMI innovativa che ha ancora ritmi di crescita da start-up (+79% sull’ultimo anno). Ma soprattutto è una comunità di persone che online e offline, ai nostri eventi e alle nostre feste, scopre e consiglia nuove letture. La più grande soddisfazione è non aver tradito quello che volevamo fare sotto il sole di Barcellona e, anzi, di averlo reso una realtà solida, capace di dare lavoro a dipendenti e collaboratori, di lanciare carriere di autori esordienti e non. Di bookabook nell’ultimo anno si è parlato all’università di Yale e alla Fiera del Libro di Francoforte. Ma sappiamo che tutto questo funziona e continuerà a funzionare finché avremo idee nuove e il desiderio di sperimentarle. Un esempio su tutti? Abbiamo appena pubblicato un libro, L’influenza del blu di Giulio Ravizza, che promuoviamo offrendo ai lettori delle esperienze interattive che completano la lettura: da un filtro di Instagram a dei Canvas su Facebook, passando per dei giochi letterari online. Con una convinzione, forse banale: è cambiato il modo in cui scegliamo i film da guardare e scopriamo nuova musica, perché il mondo del libro dovrebbe rimanere sempre lo stesso? Tomaso Greco, co-founder e Ceo di bookabook
© RIPRODUZIONE RISERVATA